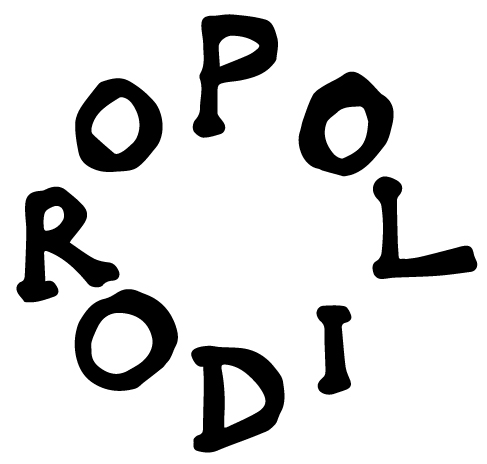FRAMMENTI DI SPAZI
Spazi guardati meticolosamente, assimilati nell’abitudine e quindi isolati in prospettiva: un angolo vicino alla porta, un pavimenti di mattonelle quadrate contro il muro, colonne, ed ampie, luminose, finestre. Nessuna annotazione biografica e nessuna indulgenza, nessuna traccia che possa riportare ad una qualche quotidianità, perché quello che conta è unicamente lo spazio tagliato in prospettive e colore, spogliato di qualsiasi indizio. In questa riduzione all’essenziale consiste l’originalità di Julie Polidoro e, contemporaneamente, il suo essere immersa in un tempo che poco ama la pittura, ma la consente se rinnovata da una profonda rivoluzione ontologica. Superata la contraddizione tra idea e materia, tra fisicità ed immaterialità anche la pittura di Julie Polidoro, ha assorbito la velocità di mezzi come la fotografia ed il video, così come la dematerializzazione del concettuale e il rigore del minimalismo, cosciente della difficoltà tutta contemporanea di esprimere con un unico e solitario linguaggio la sempre più complessa realtà del presente.
Appena terminata l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts di Parigi erano soprattutto gli utensili più comuni, un piatto, un bicchiere, una camicia lasciata ad asciugare sul termosifone, oppure panni stesi fuori da una finestra, ed essere osservati con lentezza attraverso il “mascherino”, una piccola cornice quadrata o rettangolare ritagliata dal cartone, come una personale lente d’ingrandimento sul mondo. Motivi ripetuti e isolati dal resto in una presa diretta capace di selezionare le informazioni, di eliminare il superfluo ed evidenziare l’essenziale, fino all’inquadratura migliore. Un disegno preciso calligrafico con colori che, stesi a grandi superfici, dialogavano a bassa voce in rapporti tonali vicino al grigio. Allora gli oggetti, oggi i luoghi sono allontanati dalla lroo funzione quotidiana fino all’astrazione: lo studio romano ricavato da un’aula scolastica, innanzitutto, con i banchi e la lavagna di ardesia, il soffitto e il pavimento ridotti, attraverso una meticolosa elaborazione tecnica, ad una personale geometria cromatica.
Si inzia con la scelta del supporto parte integrante del discorso pittorico, utilizzato in una serrata dialettica di luce e ombre, lucidità ed opacità, pieni e vuoti: può essere lavagna oppure carta Kraft, appena più spessa di quella da imballaggio, prima intelaiata e quindi coperta, nei lavori realizzati ad Hong Kong, da una cornice di plexiglass trasparente utilizzata per evidenziare la materia. Altre volte invece il plexiglass colorato, blu o rosso, diventa la base e allora la luce naturale viene lasciata filtrare per illuminare direttamente le forme tracciate con la tempera. Sono soprattutto polveri, diluite in colla di cellulosa e quindi opache ad essere stese con pennelli lunghi seguendo le annotazioni lasciate di giorno in giorno: brevi frasi veloci scandiscono lo spazio, per ricordare, tracce appena visibili, il lavoro già fatto e quello da fare. Quindi la scelta del colore, che definisce l’intera superficie con assonanze tonali sempre più frequentemente interrotte da un pigmento acid, quasi fluorescente: verdi freddi e grigi neutri, illuminati d’un tratto da un giallo elettrico, come un’impennata di velocità in atmosfere altrimenti rarefatte e sospese.
Un desiderio questo di movimentare gli spazi, di uscire dalle proprie “ossessioni private” testimoniato negli ultimi lavori da uno sguardo che si allarga a comprendere anche una confusa e sonnolenta umanità: come in un fumetto senza parole si susseguono still ironici da una familiarità alienata. Gli interni sono adesso abitati da personaggi appena abbozzati, chiusi nei loro gusci senza possibili aperture verso l’esterno: c’è chi guarda nel vuoto abbandonato sul divano del salotto, mentre al tavolo si mangia insieme, rigorosamente in silenzio, davanti alla tv.