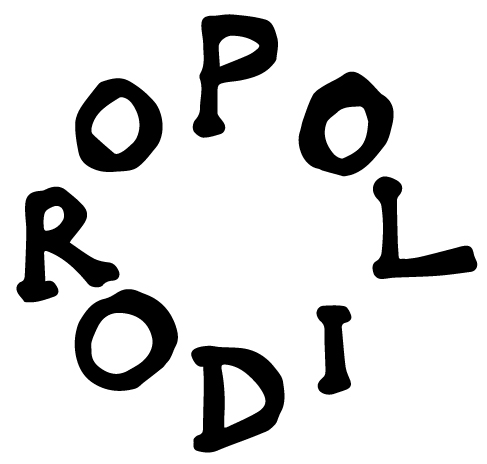ABITARE LA BUFERA
«La casa, nella vita dell’uomo, travalica le contingenze, moltiplica i suoi suggerimenti di continuità: se mancasse, l’uomo sarebbe un essere disperso. Essa sostiene l’uomo che passa attraverso le bufere del cielo e le bufere della vita».[1]»
E’ una sensazione al limite del terrore quella che trasuda dalle ultime due serie di opere di Julie Polidoro, e tanto più insidiosa in quanto la loro eleganza cromatica e il prezioso fulgore di alcune tinte (il rosa floreale del cielo in Mongolian Storm, il blu sfumato del soffitto in Parking-people, o il turchese della camicia di un operaio addormentato in The Sleepers) esercitano un’attrazione molto sensuale, quasi inebriante, sull’occhio di chi guarda. Se le tematiche divergono – da un canto gli Invisibili, esseri condannati a vivere in una condizione di esilio e confinati dalle autorità dei paesi in cui tentano di approdare, e dall’altro le tempeste di sabbia – i due corpus sono tragicamente correlati e percorsi da una medesima urgenza. Infatti, malgrado la “semplicità” del supporto (tele senza telaio appese al muro) le opere riattualizzano, lungi da qualunque spettacolarizzazione, la Catastrofe, il cambiamento climatico o le migrazioni forzate, due sintomi, tra loro inestricabilmente connessi, di una crisi di dimensioni planetarie.
Lo sfasamento temporale indotto dalle immagini da cui parte Julie Polidoro – una serie di fotografie raccolte in Rete – ne situa il gesto nell’ambito dell’incertezza e sottopone chi guarda all’attesa, quella dei migranti incerti sulla propria sorte o quella che precede lo scatenarsi della natura.
Julie Polidoro non rappresenta tanto la catastrofe – non si colloca infatti nell’alveo della tradizione romantica ottocentesca e del relativo gusto per la rappresentazione orrifica o sublime di tempeste, valanghe o naufragi dei vari Théodore Géricault, Joseph Vernet o William Turner – quanto piuttosto la declina in termini spaziali, analizzandone l’ampiezza. Come per resistere alla sua dismisura, cerca appunto di misurare l’occupazione (l’invasione della sabbia) o la negazione dello spazio (il destino di individui senza casa né patria) che tale dismisura comporta.
C’è qualcosa di minaccioso nella frontalità dei suoi Dust Storms, in quei cumuli di materiale indefinito che fanno pensare a nubi, a greggi di animali, ma anche a rilievi rocciosi, e che paiono avanzare dritti verso di noi, masse sature di violenza al limite dell’esplosione. Così come c’è qualcosa di vertiginoso nell’allineamento di corpi anonimi che popolano i suoi Invisibles, uomini e donne che occupano regolarmente le prime pagine dei media occidentali e dei quali tuttavia non si sa nulla, se non che vivono in sospeso, nella più assoluta precarietà.
In entrambi i casi, Julie Polidoro mette in atto un’opprimente saturazione dello sguardo. Da un canto, le nuvole di sabbia divorano lo spazio, anche se la stratificazione dei piani conserva il ricordo di una struttura paesaggistica. Vi si distinguono habitat delicati, il tracciato di una strada, dei campi, e forse dei pali della luce. Ma il paesaggio è progressivamente occultato e sostituito da perturbazioni atmosferiche con colori che restano mostruosi pur nelle loro sofisticate fantasmagorie.
Dall’altro, un patchwork di tappeti, asciugamani e sacchi a pelo, spezzetta i luoghi e delimita i metri quadrati attribuiti a ciascuno (Sleepers) oppure si estende, come all’infinito, sino a dissolversi in una moltitudine di forme astratte (Those Who Wait), sorta di cartografia irrisoria di territori inesistenti per un’umanità di second’ordine.
Queste vedute laterali o dall’alto, prive di orizzonte, come a suggerire l’espansione, oltre la cornice, dei materassi di fortuna o delle celle-scomparto (Sleep-box), accentuano l’affollamento che prevale negli ambienti percorsi e poi dipinti da Julie Polidoro. La quale insiste così sulle difficoltà che si incontrano, in tali circostanze, ad attribuire un’individualità gli esiliati, limitati come sono nei movimenti e accorpati a una massa ignota.
E se introduce la figura umana, cosa rara nella sua pratica artistica, è principalmente per indicare le condizioni in cui vivono dei corpi-arcipelaghi ridotti ad attività primarie – essenzialmente dormire, bere e mangiare – all’insegna di una costante promiscuità. Gaston Bachelard non diceva forse che « la casa fornisce un riparo alla rêverie, protegge il sognatore, ci consente di sognare in pace »? ) 2
Un ripiegamento interiore, questo, che è precluso ai soggetti raffigurati da Julie Polidoro. Dei sogni o degli incubi di costoro, infatti, noi ignoriamo tutto, mentre rimangono lì, muti, privi di nazionalità e di carne, invischiati nello spazio impersonale dove sono confinati.
Questa condizione, che Polidoro riesce bene a cogliere, appartiene in primis alla sospensione temporale, all’immobilizzazione illimitata, alla stasi. E’ proprio il tempo ad essere reso palpabile, dispiegando questi spazi e affrontando ciò che è irrappresentabile: lo status di individui “in transito” che non abitano un luogo, ma l’attesa. Le sue tele, la cui materialità è riaffermata attraverso i rilievi delle pieghe, rendono tangibile questo confinamento senza fine, quest’assenza di libertà che nega la possibilità di alternare azione e solitudine, « di avere tempo per sé », per dirla con Claire Marin[2].
Le pieghe, la diversa intensità e la sovrapposizione curata dei colori – segni plastici del processo creativo di Julie Polidoro e del tempo che esso implica – stanno a indicare proprio ciò di cui i migranti non possono disporre. Sottile richiamo alle diseguaglianze che dividono la società tra quelli che hanno un proprio posto e gli altri. « Il proprio luogo », sono appunto le parole che Polidoro sceglie di scrivere, tra le altre (cariche anch’esse dello stesso portato doloroso: « uscire », « cambiare posto », « tempo intimo », « altrove » ecc..), sulla superficie di Migrant Workers. Iscrizioni-incisioni che, disseminate nella foresta aranciata in cui due uomini dormono accanto alle loro biciclette, risaltano potentemente all’interno del luogo rappresentato.
Perché Julie Polidoro non manca mai di sottolineare la natura di tale realtà: dipinge infatti immagini di immagini. La presenza discreta di un telefonino, in primo piano in The Invisibles, in mano a un uomo sdraiato, con le gambe tagliate dall’inquadratura, sottolinea la perpetua circolazione delle immagini che Julie Polidoro sceglie di interrogare in questo suo nuovo lavoro. Non è banale, infatti, che un telefonino, primo supporto, insieme al computer, di queste stesse immagini, faccia qui la sua comparsa, proprio mentre Polidoro si appropria dell’odierna sovra-utilizzazione delle varie raffigurazioni della miseria migratoria, divenute ormai un cliché, persino in certi artisti. Polidoro passa al filtro dei pigmenti il substrato mediatico che è all’origine della paradossale esistenza dei migranti, sovra-esposti eppure invisibili.
Con The Invisibles, estrae dal flusso abbrutente e insipido delle fotografie e dei video che inondano i nostri schermi, una realtà condannata all’oblio non appena postata sui Social, o pubblicata sui giornali o ingoiata dal successivo servizio televisivo. E ci risveglia dall’abitudine di far scorrere o cancellare con un clic le immagini, di qualunque natura esse siano – fotografie di attualità, abiti in siti commerciali, conquiste di una sola sera su applicazioni di siti di incontri, o pop-up pubblicitari. Gesto di cancellazione di cui traspone la tacita violenza sulla tela, che viene infatti sistematicamente lacerata (Parking-people).
Danneggiando, forando il proprio medium, Polidoro lo palanca sull’oscenità del soggetto, negando al contempo la piatta uniformità dei nostri strumenti informatici, la distanza rassicurante che le loro pareti di vetro frappongono tra noi e la realtà. Inchioda dunque lo sguardo, aggiungendo, negli angoli, o lungo i bordi delle sue opere, le icone dei gesti da compiere per navigare su Internet o i dati forniti all’apertura di una finestra o di un file.
Conferisce così nuova visibilità a immagini destinate a svanire una volta condivise, ma non senza averne prima eroso l’attendibilità. Mettendole a nudo, Polidoro mina alla base l’artificialità del loro punto di vista basato su una prospettiva mono-focale e sulla frammentazione dell’inquadratura. Un « Reset » visivo che ben si riallaccia alle numerose operazioni plastiche con cui Julie Polidoro tenta di leggere il mondo in maniera diversa. Ad esempio dirottando di continuo gli strumenti cartografici per decentrare lo sguardo, presentando mappature poetiche di territori, spaginando il planisfero e i suoi confini eminentemente politici. Questa volta, ci invita a seguirla nei luoghi del disastro – cieli, palestre riconvertite o moduli prefabbricati – per ricordarci che presto saremo in numero sempre maggiore ad abitare la bufera.
¹Gaston Bachelard, La poétique de l’espace [1957], PUF, 1961, p.34-35.
² Ibid., p.34.
³ Claire Marin, Être à sa place. Habiter sa vie, habiter son corps, Éditions de l’Observatoire, 2022.
Alix Agret è una storica dell’arte. Attualmente è ricercatrice presso il Musée Matisse di Nizza.